OVERDOSE MEDIATICA: INFLUENZE E IDENTITÀ SOCIALI
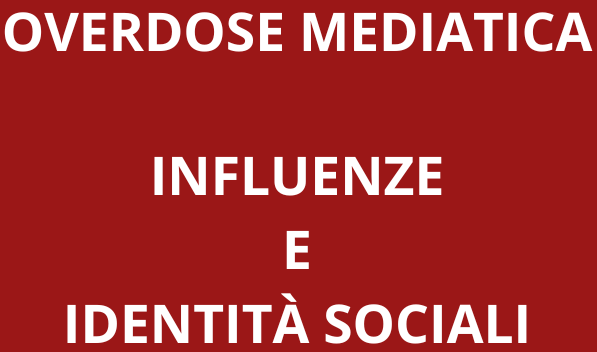
Si può ritenere condivisibile che lo sviluppo e le scoperte nell’ambito delle scienze tecnico-informatiche abbiano costituito, e costituiscano tutt’ora, forse uno degli aspetti più importanti, in termini utilitaristici, nella vita degli esseri umani.
A partire da quello che può essere considerato il primo computer universale mai creato in concreto nella storia umana, vale a dire la celeberrima macchina di Turing, l’intelligenza artificiale è stata sempre più applicata ai calcolatori al fine di riprodurre attività ritenute prettamente umane, quali la risoluzione di problemi o la dimostrazione di teoremi matematici (la cosiddetta intelligenza artificiale hard), oppure con l’ambizione di duplicare i processi mentali umani e il corrispondente comportamento a scopo di ricerca (si tratta dell’intelligenza artificiale soft).
Ecco come, ad oggi, le persone possono giocare a scacchi contro un immaginario avversario creato dal computer, eseguire esami diagnostici per prevenire l’insorgenza o l’aggravarsi di gravi patologie, acquistare prodotti introvabili nel loro luogo di residenza, financo prendere decisioni sulla vita o la morte di altre persone mediante la semplice digitazione di un pulsante. Tuttavia, al di là dei possibili impieghi della tecnologia, un punto saldo è che qualsiasi sua manifestazione, neanche quei più sensazionali simulacri costituiti da avatar umanoidi, non potrà mai integrare appieno l’essenza di una persona che espone al mondo le proprie emozioni, i propri ragionamenti, talora ingenui talaltra sorprendenti, i propri errori e fallimenti.
Così, forse anche per sopperire a questo grande divario tra le realtà umana ed informatica, l’essere umano ha introdotto sulla scena i mezzi di comunicazione di massa, o mass media, che, a partire dai primi telegrafi e radio, sono oggi incarnati nella televisione, nei principali social network, nei siti di incontri o in altri canali interattivi, in un continuo processo di antropizzazione tecnologica. Se quest’ultimo ha sicuramente i suoi punti di forza, si pensi ad esempio alla possibilità di mantenersi in contatto con l’amico, la fidanzata o il coniuge temporaneamente residenti in un altro Paese per i più svariati motivi; dall’altro lato, la facile fruibilità da parte dei consociati di video e immagini di modelli di vita pressoché impossibili da raggiungere, contribuisce a renderli dubbiosi e insoddisfatti della propria esistenza, facilitando la creazione di identità e Sé non corrispondenti alla propria natura personologica, oltre al fatto di rendere immediato il soddisfacimento dei propri desideri, così come l’appagamento libidico.
Dell’influenza di Internet sulla vita quotidiana si è cominciato a discutere sin dagli albori del World Wide Web e la pandemia da Covid-19 appena vissuta ha ulteriormente alimentato il dibattito pubblico sui punti a favore e contro un massiccio uso della rete virtuale.
Se molte aziende e industrie hanno finalmente introdotto la possibilità di ricorrere allo smart working, continuando a lasciare aperta questa porta anche dopo il termine dell’emergenza sanitaria, altre entità lavorative hanno cominciato ad aprire tale porta proprio grazie alla pandemia. Tra queste ultime entità rientra la scuola, scenario in cui è permasto, e talora permane, l’imperativo della DAD (Didattica A Distanza) la quale, tralasciando i primi ed inevitabili ostacoli ad essa connessi, ha permesso a tutti gli studenti di continuare a seguire le lezioni, studiare e incontrare i compagni e le compagne di classe.
Senza fossilizzarsi nel periodo pandemico, quanto appena riportato è soltanto uno degli accorti usi che Internet consente, facendo dimenticare a coloro che, con ogni mezzo, ne contrastano l’utilizzo e che cercano in tutti in modi di convincere una cerchia più o meno allargata di persone circa gli svantaggi della vita online. Ma possiamo ancora considerare coerente con l’attuale epoca storica questa cieca demonizzazione di Internet e, in generale, dei mass media?
Probabilmente no, soprattutto considerando l’elevato numero di attività quotidiane che effettuiamo per mezzo della rete e che spaziano dal fare la spesa al richiedere una ricetta medica, dal comprare un capo d’abbigliamento al prenotare un volo aereo per una vacanza. Inoltre, dalla loro creazione, i più svariati social network consentono pressoché a tutti di fuggire temporaneamente dalla realtà immergendosi in quel solo mondo in cui alcuni esperiscono e presentano agli altri il loro Sé più puro e sincero, introiettando contemporaneamente influenze identitarie altre dal Sé.
Specialmente quest’ultimo aspetto elicita negli adulti le maggiori preoccupazioni in ordine all’uso dei suddetti social network da parte dei propri figli, soprattutto se adolescenti, i quali si trovano sempre più esortati dai genitori ad abbandonare il mondo social in favore della realtà sociale, a sua volta da loro ricusata e ostacolata a causa dei pericoli reali ed immaginari alimentanti l’ostilità del mondo.
In altri termini, la fragile adultità dei genitori, e in generale della popolazione più anziana, esplicantesi nel non essere più in grado di tramandare valori etico-morali e civili che possano essere utilizzati dai figli come base per crearne di propri, contribuisce oggigiorno alla diffusione del paradosso di una vita che deve essere vissuta all’interno di una bolla apatica, alla larga dai pericoli del mondo sia virtuale sia reale.
Piuttosto, si potrebbe dire che sia giunto il momento in cui gli adulti insegnassero ai giovani ad essere se stessi a modo loro, a curare le proprie fragilità e difetti, così come ad utilizzare consapevolmente i rifiuti e le influenze esterni, sia reali sia virtuali, per giungere alla costruzione fedele della propria identità. Parafrasando Nietzsche, meglio divenire scriteriati con i propri sforzi, piuttosto che sapienti attraverso le opinioni degli altri.
Viviamo nell’epoca del narcisismo mediatico, un periodo storico in cui tutti, purtroppo anche coloro ai quali varrebbe soltanto il proverbio secondo cui un buon silenzio non fu mai scritto, avvertono la necessità di pubblicare contenuti inerenti momenti, eventi e, in generale, aspetti di vita che alimentano la loro quotidianità.
Tuttavia, non solo di foto e video spopolano i social media, bensì anche di immagini di figure pubbliche appartenenti al mondo dello spettacolo, sportivo o mediatico che alimentano tra il pubblico spettatore un costante gioco di introiezione della suddetta immagine e di proiezione di un Sé, di una propria identità, ad essa integrata.
Facciamo un esempio: la tazza contenente acqua bollente rappresenta l’individualità della persona, intesa come la sacrosanta variabilità individuabile che regna tra gli esseri umani; la bustina del tè immersa nell’acqua bollente costituisce l’influenza che quella specifica immagine pubblica ha sul Sé della persona, che lentamente assumerà il sapore filtrato della bustina del tè; infine, chi beve il tè non assaporerà il gusto dell’acqua bollente, bensì quello di quest’ultima (il proprio Sé) con l’aggiunta dell’aroma del tè (il Sé integrato)
Ora, lungi dal muovere critiche a quello che, in sostanza, è lo scopo dell’utilizzo dei mass media e dei social network, interessante è approfondire un minimo le principali conseguenze che una tale esposizione può avere (il condizionale e d’obbligo quando si discute su eventi sociali e umani per non cadere in fallacie deterministiche) sull’audience, con un focus specifico sulla popolazione adolescenziale.
A prescindere dal suddetto zeitgeist narcisistico dell’attuale epoca storica, visto il peso che questa fase evolutiva gioca nello sviluppo della personalità e dell’identità, l’adolescente è spinto da una connaturata volontà di offrire a tutti i costi un’immagine di sé positiva, da amare e apprezzare. Ovviamente, però, l’ammirazione è richiesta non più primariamente, ed esclusivamente, al microsistema familiare, bensì al gruppo dei pari, il che spinge molti adolescenti a conformarsi a mode, musiche, pensieri e comportamenti, in balia di quell’influenza normativa utile al solo scopo di farsi accettare dagli altri. Da qui, il classico esempio del bambino un po’ più introverso ed isolato che si conforma per riuscire a creare legami amicali e fuggire il rifiuto sociale. Non meno importante, talvolta questa manifestazione di conformismo conduce taluni adolescenti a commettere piccole attività delinquenziali.
Talora, l’influenza è di tipo informativo, ossia quando le persone danno credito ad una prova di realtà proveniente da altre persone. Banalmente, quando cerchiamo di attribuire un significato alle forme delle nuvole, le informazioni provenienti da chi ci è vicino possono rappresentare una valida fonte d’informazione (nello specifico, Caio non vede nulla in quella nuvola informe, ma Tizio gli dice che ha la forma di una palla. Caio accetta l’informazione e asserisce di vedere anche lui una palla).
Invece, per passare alle influenze mediatiche e virtuali sullo sviluppo in fase adolescenziale, le conseguenze ivi presentate sono principalmente due, entrambe estrapolate dall’intuitivo
meccanismo cognitivo per cui quanto più si viene esposti a stimoli completamente nuovi (musica, volti e rappresentazioni umane, sillabe senza senso), tanto più questi verranno ricercati e valutati positivamente, ossia il principio della mera esposizione.
Tuttavia, prima di discutere di queste ultime, di nuovo attenzione a non fare di tutta l’erba un fascio, nel senso che la verità, qualora davvero esistesse, sta nel giusto mezzo aristotelico: è ormai un dato di fatto che il mondo virtuale sia uno degli aspetti che accompagnano lo sviluppo adolescenziale, di conseguenza negarlo a se stessi e agli adolescenti costituirebbe soltanto un’ulteriore prova della fragilità adulta nei confronti di una realtà non conosciuta. Allo stesso tempo, è fondamentale accompagnare gli adolescenti anche nel processo di conoscenza del mondo online, aiutandoli a capire l’importanza di un suo uso oculato e sicuro.
È evidente lo scopo evolutivo che il suddetto principio ha avuto nello sviluppo della specie umana, ossia creare le condizioni per attrarre altre persone e creare legami d’attaccamento, ricusando parallelamente quelle che rappresentano una potenziale fonte di pericolo. In altre parole, apprezziamo maggiormente le persone a noi più vicine, mentre allontaniamo quelle percepite come più distanti.
Ora, operando una lettura tra le righe del meccanismo della mera esposizione, è possibile sostenere che le innumerevoli rappresentazioni di perfezione fisica, intendendo con ciò proprio la fisicità corporea, e di successo ad essa associato abbiano abituato la vista di gran parte degli adolescenti, i quali sempre più vanno alla ricerca di qualità più profonde, emotive e relazionali per guidare i loro giudizi, financo sublimarli od intellettualizzarli nelle più diversificate forme espressive.
Tuttavia, si potrebbe anche pensare al negativo della mera esposizione, intendendola in termini di una continua presentazione agli occhi degli adolescenti di rappresentazioni rasenti la perfezione le quali, impossibili da raggiungere, ostacolano un corretto sviluppo della propria identità e del proprio Sé. Cerchiamo di capire meglio.
L’identità di ciascuno di noi è il risultato dell’interazione tra le proprie componenti personologiche e le influenze provenienti dall’ambiente circostante, che dalla nascita fino alla prima età adulta consentiranno all’individuo di sviluppare i propri schemi del Sé, ossia organizzazioni cognitive che aiutano a selezionare le informazioni utili a strutturare e guidare la propria identità. Il punto è che in adolescenza le influenze esterne non provengono più dalla sola cerchia familiare, bensì anche, e soprattutto, da altri microsistemi quali i coetanei, la scuola o il gruppo sportivo, ai quali si aggiungono prepotentemente i mezzi di comunicazione di massa.
Nell’epoca in cui tutto deve avere uno scopo fotografico e in cui tutti devono necessariamente essere qualcuno, cosa comporta l’esposizione degli adolescenti a tali modelli di riferimento? Sicuramente, per certi individui potrebbe rappresentare un importante sprone nei confronti di ciò che si vuole diventare da adulti, consentendo a quel sogno nel cassetto di diventare realtà. Di converso, purtroppo si assiste con maggiore frequenza ad adolescenti che prendono decisioni forzate più che consapevoli, costretti a mettere da parte quella fondamentale componente dell’esistenza umana, la felicità, per riuscire nell’intento edonistico di raggiungere gli obiettivi altrui (genitori, società).
A lungo andare, tutto questo favorisce l’introiezione di ideali dell’Io ispirantisi alla perfezione, da cui l’insorgere di gelosie e invidie, di una sempre maggiore competitività, di pensare secondo le semplici ed ottuse regole del pregiudizio e dello stereotipo. Soprattutto, non consente all’adolescente di curare i suoi Sé possibili, ossia quelli che si teme di diventare e quelli che si cerca di conseguire; piuttosto, fossilizza la persona nella creazione di un falso Sé la cui funzione è di nascondere quelli che realmente sarebbero gli interessi, i desideri e gli obiettivi dell’adolescente. In altri termini, nasconde il vero Sé.
RIFERIMENTI E SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Bara, B. (2000). Il metodo della scienza cognitiva. Un approccio evolutivo allo studio della mente. Bollati Boringhieri Editore.
Lancini, M. (2023). Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta. Raffaele Cortina Editore.
Myers, D.G., Twenge, J.M., Marta, E., Pozzi, M. (2019). Psicologia sociale. McGraw Hill Education.
Palmonari, A. (2001). Gli adolescenti. Né adulti, né bambini, alla ricerca della propria identità. Farsi un’idea. Il Mulino.
Zara, G. (2005). Le carriere criminali. Collana di psicologia giuridica e criminale diretta da Guglielmo Gulotta. Giuffrè Editore.



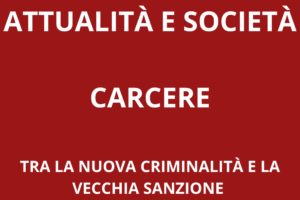
Hi there! I’m at work browsing your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading through
your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!
Thank you “drug shroom” for your comment and your appreciation. We are grateful to read that you enjoy our blog!
Please continue to follow us and help us to spread our page! We also have an Instagram one called talk.up_