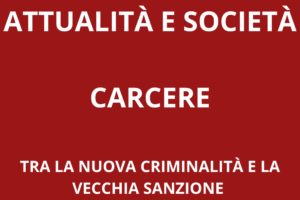ETICHETTE

Al fine di semplificare comodamente la complessità della realtà sociale, l’essere umano ha sviluppato alcune strategie cognitive che, con il passare del tempo, sono divenute delle vere e proprie etichette giudicanti e invalidanti la naturalezza delle esperienze, delle relazioni e delle passioni caratterizzanti l’essenza di una persona.
Le etichette non dovrebbero esistere in quanto la società, essendo un fenomeno umano, è cambiata, muta costantemente e sarà sempre in continua evoluzione. Quindi, ciò che si poteva ritenere naturale all’interno di uno specifico contesto storico-sociale, oggi si dimostra solo una vecchia ed ottusa idea che opprime e rallenta i cambiamenti della società, ingenerando, contemporaneamente, problemi e difficoltà in tutte quelle persone che, a causa delle etichette, si sentono diverse.
Il benessere di ciascun individuo passa attraverso l’incondizionata accettazione di tutte quelle componenti (dall’amore ad un semplice hobby) che fanno stare bene una persona. Di conseguenza, etichettare tutti questi aspetti contribuenti alla definizione dell’identità personale, significa intaccare e pregiudicare la sfera privata del soggetto stesso.
Ma chi è, in fin dei conti, a stare male? Stanno peggio, ad esempio, due partner omosessuali che si amano incondizionatamente, oppure coloro che si sono arresi ai dettami di un amore imposto da presunti dogmi socio-culturali e religiosi? Colui che è spaventato dalla varietà umana, oppure colui che vive (si spera) liberamente tale varietà?
Le diverse definizioni dell’aggettivo naturale consentono di ottenere quel comune denominatore racchiudente in sé il significato di un qualcosa di attinente e fedele alla realtà osservabile, in termini sia di elementarità (colore, forma, materiale ecc.) sia di funzioni e competenze. Sostanzialmente, naturale è tutto ciò che si può incontrare nel mondo così come si presenta. Ma, allora, perché dovrebbe essere innaturale che una donna ami un’altra donna? Perché non sarebbe naturale che un uomo pianga in un momento di sconforto e che una donna si dimostri, invece, forte e irreprensibile?
Per rispondere a queste domande si può affermare che la quasi totalità dei membri dell’attuale società non è in grado di svincolare il concetto di naturale da antichi ed ottusi costrutti ed introietti che, sia per pigrizia sia per ignoranza, non si sono mai voluti superare.
Estremizzando questo ragionamento, si potrebbe anche aggiungere che l’esasperata opera di attribuzione di etichette messa in atto dalla società al fine di mantenere il controllo su chi e su cosa possono rientrare all’interno del concetto di naturale, sia essa stessa a creare la devianza.
Ad esempio, il sociologo francese Émile Durkheim riteneva che deviante fosse la persona che avesse ricevuto una tale etichetta da parte della comunità, piuttosto che colei che avesse violato la legge. Da qui muove il pensiero di autori quali Becker e Lemert. Il primo sostiene che la devianza sia il frutto di un processo di interazione sociale tra coloro che impongono le etichette e quelli che, a causa di queste ultime, attribuiscono un certo significato al proprio comportamento, così da divenire i principali artefici dell’etichetta loro attribuita. Per assurdo, si immagini che venga varata una norma che vieti di avere sulla pelle dei tatuaggi esclusivamente di colore nero, come se ne possono osservare molti in giro. Bene, coloro che si erano fatti tatuare solo con il colore nero prima del varo della suddetta norma potrebbero cominciare ad essere etichettati dal resto della comunità come dei fuorilegge, così che, rimuginando su un proprio comportamento passato, alla fine saranno loro i primi a considerarsi devianti.
Allora, ecco subentrare la stigmatizzazione di cui parla Lemert, ossia quel processo sociale che mira ad identificare apertamente le persone considerate moralmente inferiori a causa di un’erronea attribuzione di un’etichetta, proprio come nell’Antica Grecia gli schiavi, i traditori o i criminali subivano l’onta dello stigma, che per l’appunto significa macchia, puntura. In questo modo, il soggetto marchiato comincia a ripensare alla propria esistenza, fino ad accondiscendere l’etichetta che gli è stata imposta. Alla fine, la persona rimarrà bloccata in un limbo comportamentale deciso dalla società, così che ogni suo singolo comportamento verrà etichettato conforme o meno ai dettami normativi sulla base di quanto deciso da altri.
Quanto appena presentato è il rischio che si corre nel momento in cui si cerca di rinchiudere un costrutto polimorfo come quello di naturale, in grado di abbracciare fino alle più piccole sfumature dell’esistenza. La naturalezza è racchiusa nella spontaneità della varietà fenomenologica, ma specialmente nella capacità di saper guardare il mondo con curiosità, intraprendenza e con la giusta dose di ingenuità. In questo modo, non si apprezzerebbe soltanto il diamante in un mare di semplici sassi, bensì anche la diversità delle semplici pietre l’una dall’altra.
Piuttosto che attaccare il concetto di naturale con sempre nuove etichette soltanto per fuggire alla paura di affrontare la varietà che esso è in grado di offrire, bisognerebbe porsi nei suoi confronti con la stessa ammirazione ed umiltà che ha il pastore errante dell’Asia Centrale leopardiano nel momento in cui egli, parafrasando, afferma: io che cosa sono rispetto all’immensità del cielo, della terra e delle stelle? Penso a questo quando parlo tra me e me, ossia alla vastità e alla grandiosità dell’universo e alla sterminata famiglia degli esseri viventi.
Una famiglia allargata quella degli esseri viventi, all’interno della quale, mai come in altre, vale il detto popolare parenti serpenti. Infatti, l’appartenenza alla medesima cerchia familiare non ha mai garantito e, forse, mai garantirà l’assenza di problematiche.
Una delle più diffuse e radicate, specialmente nel mondo occidentale, è quella discriminatoria, financo razzista. L’etichetta del diverso e, di conseguenza, da evitare e, se possibile, eliminare è estremamente longeva: si pensi a tutte le guerre mascherate dalla Religione che, in realtà, hanno avuto e hanno l’obiettivo di espandere i territori di taluni Stati e di eliminare il diverso; si pensi alle più esplicite forme di discriminazione nei confronti degli afroamericani negli Stati Uniti, piuttosto che all’apartheid in Sud Africa, oppure alla segregazione raziale dei regimi fascista e nazista; ma si pensi anche alla discriminazione nei confronti degli immigrati italiani, ebrei ed est-europei negli USA degli anni ’20, i quali venivano sottoposti ad insensati test intellettivi (si basavano sulla conoscenza della lingua e della legislazione nord americane, di conseguenza è chiaro quale fosse l’esito principale di tali test) per favorire l’ingresso nel Paese soltanto a persone con il cervello sano.
E gli esempi potrebbero continuare. Ovviamente, in quelli citati l’etichetta del diverso assume un’accezione fortemente negativa e, per l’appunto, discriminatoria. Ma fino a che punto è possibile riferirsi ad una persona di etnia differente alla propria senza sfociare nell’attribuzione di un etichetta o essere a propria volta etichettati come razzisti dal resto della società? Probabilmente la risposta a questa domanda risiede sempre nella spontaneità, nella naturalezza, con cui ci si rivolge ai vari costituenti quella che si è definita in precedenza la famiglia allargata degli esseri umani, senza dover sempre sospettare di una presunta malizia nelle parole impiegate.
Dunque, ribadendo la non volontarietà discriminatoria dei termini utilizzati, il fatto di alludere al colore della pelle di una persona per riferirsi a lei in un gruppo di persone non dovrebbe dare di che pensare. Questo specialmente se si considera nuovamente il fatto che l’essere umano, in quanto essenzialmente cognitive miser (letteralmente avaro cognitivo), necessita di scorciatoie mentali per semplificare la realtà in cui risiede.
Quindi, ad esempio, se in un gruppo di cinque amici uno di loro fosse afroamericano, non ci sarebbe nulla di sbagliato nell’utilizzare il colore della sua pelle come punto di riferimento per semplificare i tempi di pensiero e riferirsi a lui nel più breve tempo possibile. Così, se venisse chiesto: “Chi dei cinque amici è Marco?” e si rispondesse: “Marco è il ragazzo nero”, pur avendo impiegato un’etichetta, essa ha assunto una valenza descrittiva utile al contesto.
Il senso è che, talora, è anche utile liberarsi da una sfrenata e forzata ricerca del politicamente corretto, perché questo, a sua volta, potrebbe tradursi nell’attribuzione di etichette da parte di chi ostentatamente cerca di eliminarle.
Purtroppo, però, come spesso si suol dire tra il dire e il fare c’è di mezzo una gran quantità di ostacoli, al punto tale che a ricevere probabilmente il più grande numero di etichette è l’aspetto più variopinto dell’esperienza umana: l’amore. Cercando di svincolarsi dai numerosi appellativi, forse discutibili, che sono stati formulati per indicare la tavolozza di colori degli orientamenti sessuali (oltre all’omo-/eterosessualità si pensi alla bisessualità, alla pansessualità, all’asessualità ecc.), ancora oggi questi ultimi vengono utilizzati da molte persone come filtri per decidere se poter effettivamente frequentare un’altra persona, oppure una certa compagnia di individui, oppure ancora se permettere a figli e/o a parenti di trascorrere del tempo con determinate persone.
È aberrante che la vita sentimentale non riesca a svincolarsi da vecchie ed ottuse concezioni costruite dalla società al fine di delineare un cieco modo di vivere le relazioni umane, le quali, per costruirsi, non necessitano della conoscenza dell’orientamento sessuale dei due, o più, individui coinvolti. Non ha alcun senso, e risulterebbe alquanto inappropriato, presentarsi a qualcuno chiedendogli se sia etero od omosessuale, bisessuale e così via.
Ad alimentare le etichette concernenti l’amore e la sessualità, nello specifico i rapporti sessuali omoerotici, vi è ancora una volta l’influenza esercitata dalla Religione. Infatti, ad esempio, nel Nuovo Testamento (il Vangelo) sembrerebbe mai trasparire dalle parole di Cristo un sentimento di riprovazione nei confronti dei rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso.
Di contro, si può leggere un chiaro astio nei confronti di questi ultimi dagli scritti dell’Antico Testamento (la Bibbia), ad esempio nella prima lettera di San Paolo ai Corinzi: “Non illudetevi: né immortali, né idolatri, né adulteri, né effemminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il Regno di Dio” (I Cor 6, 9-10). Da qui, l’inizio di una sorta di Crociata civile per difendere quel sentimento xenofobico connaturato alla Chiesa stessa per mascherare, in primis, l’ignoranza e la pigrizia delle interpretazioni delle Sacre Scritture, così come la volontà di preservare l’atto sessuale per un mero scopo riproduttivo.
A tal proposito, curiosa è l’incoerenza di una simile ossessione se si pensa che, ad esempio, la casta clericale è costituita da maschi cui è interdetto ogni tipo di rapporto sessuale sin dai primi momenti di vita all’interno dei seminari. In questo modo, l’unico modo per colmare la mancanza fallica e l’immaturità sessuale ed emozionale è lo sviluppo di un narcisismo religioso che fa credere ai chierici di porsi come diretti intermediari tra il Sacro e il profano.
Inoltre, suggestiva è anche questa riflessione: se la procreazione è l’unico scopo dell’unione sessuale, e quest’ultima è l’unico mezzo tramite il quale raggiungerla, come mai il Cristianesimo sembra chiudere molti occhi sul fatto che Gesù non sia stato concepito durante un rapporto sessuale, bensì tramite quella che parrebbe essere la prassi della fecondazione in vitro? Senza doversi necessariamente sforzare per cercare di fornire una risposta alla sopraffatta riflessione, basti leggere i seguenti passi del Vangelo di Luca: “Lo Spirito Santo scenderà su di te [Maria], su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio” (Lc 1, 35).
Tutto questo anche a causa dell’esistenza di quell’etichetta spesso errata che fa coincidere l’amore con il rapporto sessuale. Di per sé, questi ultimi non sono propriamente sovrapponibili, nonostante colloquialmente l’espressione fare l’amore venga impiegata interscambiabilmente per riferirsi al sesso. In ogni modo, se da un lato è certamente innegabile che alla base di molti rapporti sessuali ci sia un solido sentimento di amore, dall’altro lato quest’ultimo è totalmente assente.
Di contro, l’amore può essere inteso come quella spinta innata che, sulla base della sua interazione con l’ambiente di sviluppo e con le personali esperienze pregresse, consente a due persone di provare serenità e piacere nel solo stare in compagnia, financo unirsi in una vita di coppia all’interno della quale regnino la fiducia e il rispetto reciproci, di cui l’aspetto sessuale ne costituisce una delle tante componenti, certamente importate, ma non primaria.
L’amore è veramente quel meccanismo che, riprendendo Dante, move il sole e l’altre stelle, che permette la condivisione di gioie e dolori e che, nell’incontro tra due orientamenti sessuali, si traduce nel raggiungimento di un reciproco piacere, di una maggiore conoscenza del proprio e dell’altrui corpo secondo i principi del rispetto, dell’attenzione e della complicità. Per questo, sin da bambini bisognerebbe insegnare agli individui ad attribuire maggior valore a quelle variabili davvero in grado di avvicinare due persone, quali l’ambiente in cui esse si incontrano, le esperienze che esse condividono, la certezza di poter trovare un porto sicuro nei momenti di difficoltà, piuttosto che fomentare in loro la costruzione di mentali barriere architettoniche utili soltanto ad ostacolare sia l’etichettamento delle persone a livello sessuale sia la libertà di espressione a livello sentimentale.