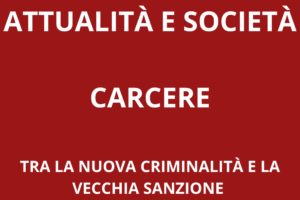LA MATRICE DELLE ETICHETTE

L’etichetta più logorante il sentimento di civiltà che dovrebbe caratterizzare ogni società, nonché quella che ha portato alla creazione e all’esacerbazione in negativo di tutte le altre etichette, è quella relativa alla distinzione delle caratteristiche che fanno di una persona un vero uomo, piuttosto che una vera donna.
Si tratta della matrice di tutte le altre etichette, in quanto, per non cedere passivamente all’oppressione di un sistema ideologico archetipico ed ottuso, tutte quelle persone emarginate ed evitate hanno iniziato a creare a loro volta delle etichette, talora attribuendosene volontariamente, allo scopo di difendere la libertà dei propri sentimenti e del proprio arbitrio, per riuscire ad affermarsi nella società e per poter comunicare la propria esistenza.
Un certo grado di ostentata positività tossica potrebbe condurre taluni alla conclusione per cui tutto questo sia sufficiente per scardinare una simile ideologia, ma in questo modo si peccherebbe di ingenuità. Infatti, se, da un lato, i tempi sono certamente cambiati rispetto a passati periodi storici durante i quali le manifestazioni di dissenso venivano ferocemente represse con la forza, escludendo da questo discorso sia la problematica dell’attuale discriminazione raziale negli Stati Uniti sia la situazione di quei Paesi in cui non a tutti è concessa la libertà di espressione; dall’altro lato, a regnare oggigiorno è la sottigliezza dei molti escamotage attraverso cui la gerontocrazia di pressoché tutte la Nazioni del mondo cerca di ostacolare il raggiungimento di importati obiettivi sociali ed umani.
E questo non può far altro che ferire gli sforzi e l’impegno profusi da tutte quelle personalità che, a partire dall’Umanesimo, passando per l’Illuminismo, per arrivare ai movimenti femministi delle età contemporanea e moderna, hanno avuto l’ardore di sfidare l’ottusità dell’ideologia imperante, fondando così le basi di una tanto necessaria parità di sesso. È, dunque, evidente che la potenza di questa etichetta non può essere affrontata solamente organizzando iniziative di facciata, piuttosto che escogitando delle politiche sociali tutt’altro che accattivanti. Al contrario, risulterebbe davvero necessario agire a livello educativo, culturale e comunitario per contenere la cieca influenza della suddetta distinzione e bloccare il proliferare di tutte le altre etichette.
Ma in che cosa consiste la matrice delle etichette? La sua essenza risiede nella convinzione di quei non detti comunitari richiamanti costantemente quali sono, o devono essere, le caratteristiche formanti l’uomo e quali, invece, quelle che rappresentano la piena femminilità.
Così, da un lato si è diffusa la rappresentazione del fantomatico vero uomo, ossia colui che non piange, che deve lavorare per mantenere una famiglia fortemente voluta, che non fallisce, che ha passioni più pratiche e meccaniche (ad esempio le automobili) e che non può sposare un altro uomo. Per contro, la donna per eccellenza sarebbe colei che accudisce il marito e la famiglia, che se lavora lo fa per necessità economiche in quanto priva di ambizioni di carriera, che può/deve esprimere le proprie fragilità per non essere etichettata maschiaccio e che manifesta interessi e passioni per attività culturali ed artistiche (ad esempio, la pittura o la lettura).
Classici cliché che, a causa delle loro silenziosa e costante compresenza in tutti gli aspetti dell’esistenza umana, nel momento in cui non vengono orgogliosamente assunti da talune personalità, possono condurre ad una sorta di asfissia emotiva in coloro che, invece, in essi non si riconoscono. Questo, inoltre, potrebbe potenzialmente condurre all’incapacità di gestire appieno per se stessi determinate esperienze della vita.
Ad esempio, sono spesso evidenti le differenze di genere nel corso di un processo di elaborazione del lutto, per cui se le donne non si esimono dal versare lacrime, gli uomini rimarrebbero forti ed impenetrabili innanzi la sofferenza. Questo, quanto meno, a livello di senso comune, anche se la letteratura scientifica ha, comunque, teorizzato l’esistenza di due distinti stili di reazione al lutto: l’uno pratico, l’altro istintivo. Intuibile è il motivo di tali denominazioni. In ogni modo, se una modalità pratica di affrontare un lutto si esplica attraverso la razionalizzazione e l’intellettualizzazione del fatto, insieme ad una maggiore volontà di trascorrere del tempo in solitudine, lo stile istintivo si fonda sulla ricerca di sostegno sociale e sulla piena esternalizzazione delle emozioni. L’uno è orientato al fare, l’altro al sentire.
Come sempre, non si può fare di tutta l’erba un fascio, nel senso che è chiaro che i suddetti stili di elaborazione del lutto possono essere impiegati interscambiabilmente da tutti i generi. Fatto sta che, dagli studi sul tema, emerge un maggior impiego del primo stile da parte degli uomini, insieme ad un maggior ricorso al secondo da parte delle donne. Ecco, allora, una domanda alla quale ciascuno può tentare di formulare una risposta: l’appena riportata distribuzione degli stili corrisponde effettivamente alla reale essenza degli uomini e delle donne che hanno accettato di sottoporsi allo studio, oppure ha anch’essa risentito dell’influenza di quella che viene qui definita la madre di tutte le etichette?
Ora, dal quadro sin qui delineato sembrerebbe trasparire una costante ed implicita ricerca di complementarietà degli aspetti dell’esistenza, non da ultimo tra uomo e donna. Così, come si è detto in precedenza, la mancanza di emotività maschile dovrebbe poter essere colmata dall’espressività femminile, oppure se la società vuole che sia l’uomo a lavorare, allora sarebbe necessario che la donna si dedicasse alla gestione della casa. E via dicendo con i non sensi.
La complementarietà si definisce sulla base dell’utilità delle parti di un sistema in quanto tali, quindi descrivibili e considerabili solo se poste in rapporto reciproco, proprio come i pezzi di un puzzle possono assumere un certo ruolo solo quando messi in relazione l’uno con l’altro così da creare l’immagine completa. Così, l’uomo e la donna, insieme alla loro complementarietà sessuale, costituirebbero i capi saldi di quel povero ed erroneo quadro dipinto dalla visione giudaico-cristiana dell’essere, secondo cui l’universo sarebbe popolato esclusivamente da coppie complementari (sacro e profano, luce e tenebra ecc.), di modo che ogni singola componente del mondo si esaurisca in termini di un’esistenza servente a colmare il vuoto di un’inesistenza, niente di più. A tal proposito, recita così l’Havdalah, ossia la preghiera ebraica recitata alla fine dello Shabbat: “Tu sei benedetto, o Signore nostro Dio, Re dell’universo, perché hai distinto tra sacro e profano, tra luce e tenebre, tra Israele e le altre nazioni, tra il settimo giorno e i sei giorni di lavoro”.
È opportuno che la società contemporanea abbandoni una tale prospettiva depauperante la vitalità e la natura di ogni singola persona, per adottare un sentimento di co-costruzione di tutte quelle componenti del Sé, piuttosto che di tutti quegli aspetti della realtà che, in autonomia, non si è in grado di sviluppare, o creare. In questo modo, a livello del singolo individuo, l’incontro tra le qualità, le capacità e le conoscenze delle persone consentirebbe di coltivare e valorizzare tutti quegli aspetti che, altrimenti, non riuscirebbero a trovare il modo di sbocciare appieno.
Parallelamente, sul piano comunitario, la condivisione e l’utilizzo reciproco delle rispettive proposte e ideologie garantirebbe una maggiore possibilità di costruire una realtà sociale svincolata da etichette e da concezioni preconfezionate. Inoltre, consentirebbe nelle persone l’acquisizione di una maggiore auto-consapevolezza, unitamente ad una più profonda conoscenza ed espressione dei propri sentimenti e della libertà di amare senza filtri. Ancora, relativamente al sistema famigliare, eviterebbe la trasmissione intergenerazionale di vecchi ed ottusi modi di pensare utili soltanto ai genitori per plasmare i figli a propria immagine e somiglianza, così da poter usare narcisisticamente questi ultimi per vivere costantemente una giovinezza ormai passata.
L’obiettivo è quello di far decadere un sistema omeostatico di ottusità, pregiudizio ed etichettamento fino ad ora accettato ciecamente dalla società per motivi sia di convenienza sia di chiusura mentale. Solo un impegno attivo e congiunto permetterà alle persone di spogliarsi dai pesanti vestiti delle etichette per muoversi con leggerezza e spontaneità nel mondo.