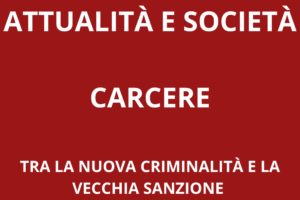CARCERE

INTRODUZIONE
TRA LA NUOVA CRIMINALITÀ E LA VECCHIA SANZIONE
La criminalità costituisce un fenomeno antico e strettamente connesso all’evoluzione della società, infatti dal primo omicidio commesso dal biblico Caino nei confronti del fratello Abele, si è giunti alle più innovative e subdole forme di truffe informatiche. Con questo, si vuole intendere essenzialmente che, così come le persone sono riuscite a progredire e ad innovarsi in praticamente ogni aspetto della loro esistenza, anche i comportamenti anti-giuridici sono andati sempre più incontro ad un processo di costante aggiornamento e adeguamento ai diversi periodi storici.
Lo stesso non si può certamente dire riguardo alla normativa giudiziaria, la quale non pare in grado di intendere che dietro ai fatti di reato in sé e ai processi sanzionatori conseguenti ci sono delle persone, le quali possono delinquere per i più svariati motivi tra loro concatenati, così da essersi trovate, sotto certi punti di vista, costrette a farlo. Infatti, quando si parla di comportamento criminale, risulta al quanto riduttivo pensarlo e spiegarlo in termini di causalità lineare, per cui ad una data condizione seguirebbe direttamente una certa conseguenza.
Quindi, non sarà una singola causa la determinante di un certo comportamento criminale, bensì la combinazione delle caratteristiche della persona, delle sue condizioni economico-sociali, della potenziale presenza di patologie psichiatriche, nonché delle esperienze di vita pregresse ed attuali e così via. Si pensi, ad esempio, ad un bambino proveniente da un malfamato e povero quartiere di periferia, circondato da adulti di riferimento per i quali la criminalità costituisce il principale, nonché più veloce, modo per far fronte alle avversità socio-economiche e alla marginalità cui sono sottoposti dal resto della società. Tuttavia, sarà la compresenza delle condizioni suddette, piuttosto che ciascuna di esse prese singolarmente, a far sì che quel bambino, nato e cresciuto in un tale contesto, abbia in un futuro una maggiore probabilità di incorrere in agiti criminali e, chissà, sperimentare per un certo periodo della sua vita l’esperienza carceraria.
Con ciò non si vuole cedere ad un cieco determinismo, in quanto è sempre d’obbligo tenere in considerazione gli aspetti di variabilità individuale (in termini, ad esempio, di più solide difese mentali, piuttosto che di influenze prosociali provenienti da altri gruppi di riferimento), bensì sottolineare che nessuna delle tante cause di un potenziale agito criminale è di per sé né sufficiente né necessaria se non considerata insieme ad altre condizioni.
In questo modo, la medesima condizione carceraria può essere considerata una condizione alla quale concorrono numerose cause, in un’ottica tanto di risocializzazione quanto di aumento della recidiva o di altre problematiche. Infatti, la proporzionalità della pena rispetto al fatto di reato commesso, l’adeguatezza delle strutture detentive, del personale penitenziario e dei servizi per i detenuti, l’offerta di opportunità lavorative extra-moenia (ossia esternamente al carcere) piuttosto che di altre iniziative atte a favorire una continuità relazionale tra il dentro e il fuori del carcere sono sole alcune cause che, nelle loro diverse modalità di interazione, possono sia acuire il rischio di ricaduta criminale o suicidario, sia fare in modo che la parentesi detentiva sia davvero trasformativa per la persona, garantendo a quest’ultima la reale speranza di potersi reintegrare nella società libera.
Ora, se la criminalità è andata, va e andrà in contro ad un costante aggiornamento e adeguamento rispetto allo spirito dei tempi, come mai la legislazione giuridica rimane, tuttora, saldamente ancorata ad una vecchia idea di pena e di carcere de-umanizzante la persona del reo?
In parte si è già risposto in precedenza al quesito appena posto: nel momento in cui il progresso e l’innovazione arrivano a toccare ogni aspetto dell’esistenza umana, anche la criminalità non può che adeguarvisi. Invece, per quanto concerne la seconda parte della domanda di cui sopra, si potrebbe ribattere che, di contro al fenomeno della criminalità, quei pochi e vecchi individui che si sono passati la fiaccola della lotta alla crimine abbiano sempre cercato di preservare un arcaico sistema sanzionatorio, i cui pochi progressi rispondevano non alla domanda relativa a come rendere veramente più umana e risocializzante l’esperienza detentiva, come richiesto dall’art. 27, c. 3 della Costituzione italiana, bensì a quale sia il metodo di detenzione, o in generale quale sia la pena, più efficace.
Per quanto concerne l’Italia, gran parte della disciplina inerente l’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale è contenuta nella legge n. 354 di Ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975, al quale si accompagna il regolamento emanato tramite Decreto del Presidente della Repubblica, ossia il D.P.R. del 30 giugno 2000 n. 230.
Tuttavia, prima del 1975, passando dallo stato liberale al regime fascista e, infine, all’Italia repubblicana, si è manifestata una certa continuità in materia penitenziaria sulla base di tre aspetti:
- l’idea di carcere come un luogo impermeabile ed isolato rispetto alla società libera, così da creare un contesto caratterizzato da significative emarginazione e separazione;
- la diffusione, all’interno degli istituti di pena, di un clima di tensioni e violenze tanto tra i detenuti, quanto tra questi ultimi e il personale penitenziario. Tutto questo fomentato ulteriormente dalla circolazione di regole altamente vessatorie e punitive per i detenuti;
- la presenza di un’amministrazione penitenziaria fortemente centralizzata, verticalizzata e verticistica, la quale non garantiva adeguate e repentine risposte alle richieste della popolazione detenuta.
Ciononostante, neanche con il passaggio alla Repubblica e all’entrata in vigore della Costituzione la faccenda è cambiata. Infatti, si è dovuto attendere il 1975 per poter cominciare ad ottenere un ordinamento penitenziario adeguato e conformato ai principi costituzionali.
In primis, la riforma del 1975 ha consentito il transito da un sistema penitenziario governato dalle decisioni del potere esecutivo ad uno regolato dalla legge, che trova la sua ragion d’essere nei principi della pubblicità e del contradditorio tra le forze politiche di maggioranza ed opposizione. Questo passaggio ha garantito che le decisioni in materia penitenziaria non risiedano nelle sole mani del partito di maggioranza, bensì che siano formulate, discusse ed approvate dall’insieme delle forze politiche rappresentative della volontà popolare, ossia il Parlamento.
Se, da un lato, quanto appena riportato ha consentito che non sia il singolo partito politico a capo del governo a prendere decisioni a proprio piacimento su come e quanto sanzionare un certo reato, dall’altro lato ci si trova ancora di fronte all’incapacità delle forze politiche di riuscire a far convergere le rispettive opinioni in singoli provvedimenti che davvero contribuiscano a svecchiare ed umanizzare il sistema sanzionatorio.
Tra i contenuti principali della legge 354/1975 se ne annoverano due in particolare. Il primo si riferisce al pensiero del trattamento penitenziario individualizzato (art. 13 ord. pen.) che, tramite il metodo dell’osservazione scientifica della personalità, dovrebbe accompagnare, in un condizionale che è d’obbligo, la persona sin dalla sua entrata nell’ambiente detentivo e terminare solamente con la fuoriuscita della stessa dal carcere. L’obiettivo primario è la risocializzazione del condannato, per la quale il legislatore avrebbe predisposto i seguenti elementi per un adeguato trattamento penitenziario: l’istruzione, il lavoro, le attività culturali, ricreative e sportive, la religione, i contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.
In questo modo, è venuta meno quella vecchia percezione di carcere in termini di calderone indistinto di criminali tutti uguali e necessitanti lo stesso programma penitenziario. Così, anche assorbendo le conoscenze e le innovazioni provenienti dai diversi ambiti delle scienze forensi, si è capito che ciascun individuo che entra in carcere necessita di un trattamento pensato su misura delle risorse, delle potenzialità e delle necessità della singola persona.
Sicuramente, però, l’elemento veramente innovativo della riforma del 1975 è stata l’introduzione delle misure alternative alla detenzione in carcere, ossia di quelle modalità di esecuzione della pena detentiva in forma parzialmente o totalmente extra-muraria. Di seguito, a scopo meramente informativo, si elencano tali misure:
- l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.);
- l’affidamento in prova in casi particolari (art. 94, D.P.R. n. 309/1990) per i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti;
- la detenzione domiciliare (art. 47-bis e seguenti ord. pen.);
- la semilibertà (art. 48 e seguenti ord. pen.);
- la liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.).
Dunque, si tratta di provvedimenti che devono limitare la libertà personale del condannato, seppur in forma ridotta rispetto ad una sanzione detentiva, conseguendo parallelamente lo scopo di risocializzare l’autore di reato (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020).
Ma allora, non sarebbe possibile intendere le misure alternative alla detenzione in carcere come la prassi, piuttosto che come un’alternativa vera e propria? Ossia, se in un’ottica di pena il ricorso al carcere dovrebbe costituire l’extrema ratio, nel senso che esso dovrebbe essere applicato nel momento in cui qualsiasi altra misura limitativa della libertà personale non dovesse risultare utile, non sarebbe congeniale pensare di applicare in primis un misura alternativa che punti veramente sin da subito a garantire la risocializzazione del reo?
Si pensi, di nuovo, al bambino nato e cresciuto in quel quartiere malfamato in cui povertà e delinquenza sono all’ordine del giorno. Si aggiunga a questo il far parte di una famiglia, piuttosto che di un gruppo di pari, all’interno dei quali si veicolano messaggi di violenza, marginalità e conflittualità. Tutti insieme, questi fattori aumentano la probabilità che quel bambino, ormai giovane adulto, commetta un reato, ad esempio un furto per far fronte alla condizione di povertà in cui versa. Infine, si immagini che gli venga comminata una pena detentiva di cinque anni (il reato di furto è sanzionato dal Codice penale – art. 628 – con la reclusione da tre a dieci anni).
Ora, la domanda che ci si può porre è la seguente: è davvero necessario che il nostro individuo che, sotto certi punti di vista, è stato portato a delinquere dalla sua condizione esistenziale venga rinchiuso per tutti quei cinque anni nella più gettonata scuola di criminalità qual è il carcere?
Quanto viene qui proposto si esplica in questi termini: piuttosto che isolare dalla società una persona aumentando la probabilità che, una volta fuoriuscita dal carcere, essa torni a delinquere, si potrebbe optare per un periodo di reclusione di massimo due anni, così da farle toccare con mano la limitazione della libertà e dello spazio personali, così come la durezza del vivere all’interno dell’istituzione carceraria. In seguito, i restanti tre anni di pena verrebbero trascorsi nella società libera, nella quale la persona avrà la possibilità di dedicarsi a lavori socialmente utili, financo a lavorare con contratto e con possibilità di assunzione futura, piuttosto che a studiare o a dedicarsi ad altre attività socio-culturali. In questo modo si potrebbe effettivamente iniziare il percorso di re-integrazione all’interno della società certamente durante il periodo di reclusione, però all’esterno delle influenze negative che il carcere comporta.
Ovviamente, qualora l’individuo non dovesse cogliere l’opportunità che gli è stata offerta verrà ricondotto in carcere.
Nella pratica, non si è effettivamente molto distanti da quello che è il senso di molte misure alternative alla detenzione in carcere, piuttosto che all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova (legge n. 67 del 28 aprile 2014). In ogni modo, la ratio sottostante la suddetta proposta risiede nella necessità di anticipare i tempi di re-integro della persona nella società libera, così da limitare al massimo la vita intra-muraria, favorendo sin da subito la risocializzazione del condannato.
A tal proposito, se nell’ordinamento giuridico italiano, da Costituzione, non dovrebbe esistere il famigerato fine pena mai si potrebbe pensare di non rinchiudere l’ergastolano in una cella potenzialmente a vita, quanto piuttosto operare al fine di creare delle strutture giuridiche residenziali all’interno delle quali far risiedere i condannati alla pena dell’ergastolo, ovviamente sulla base dell’anonimato della causa per cui la persona avrebbe ricevuto una simile condanna, dove loro possano in un certo senso autogestirsi e provvedere ai bisogni della comunità stessa. In questo modo, l’economia sociale delle carceri risulterebbe meno incline ad aumentare i tassi di sovraffollamento e, inoltre, ciò consentirebbe di attuare a pieno le misure rieducative pensate tanto per i detenuti all’interno delle carceri, quanto per gli ergastolani all’interno delle comunità residenziali.
Il tutto considerato anche da un punto di vista economico: ogni detenuto costa allo Stato italiano circa 137 euro al giorno, così da arrivare annualmente, considerando che la popolazione carceraria consta di circa sessanta mila detenuti, ad un costo di tre miliardi di euro. Se si cercasse di tenere il più lontano possibile dalle celle gli autori di reato, gli istituti penitenziari richiederebbero meno costi da parte dei consociati e quei soldi risparmiati potrebbero essere impiegati per fornire effettivamente sostegno, attività e percorsi terapeutici a quelle persone che, per forza di cose, in carcere devono rimanere.
Ora, sicuramente la riforma del 1975 ha costituto una svolta importante in materia penitenziaria. Tuttavia, si è trattato di un piccolo passo verso un sistema penitenziario davvero in grado di dare un senso di umanità all’esperienza detentiva, tratto che, tuttora, tarda a mostrarsi. Probabilmente, la colpa non è di un sistema penitenziario incapace di adattarsi ai tempi e alle richieste di umanità, bensì di quella porzione di popolazione che non sa, o non vuole, svecchiarsi da un’idea di carcere e di pena ancora risalente a quanto statuito dal Codice Penale Rocco (dall’allora Ministro della giustizia Alfredo Rocco) del 1930.
A tal proposito, non tanto anziana è l’idea secondo cui il ricorso alle celle di isolamento possa davvero neutralizzare la potenzialità criminale delle persone detenute. Ad esempio, risale solo al 1829 l’inaugurazione dell’Eastern State Penitentiary di Philadelphia, attivo fino al 1971. Si trattava di un istituto penitenziario con una capienza di 582 detenuti, la cui pianta radiale, costituita da sette bracci, favoriva sicurezza, igiene e facile gestione. Tuttavia, la filosofia ispiratrice dell’istituto era quella dell’isolamento: ogni detenuto accedeva ad un piccolo cortile circondato da mura, così da non poter mai incontrare i compagni di reclusione. L’isolamento aveva, quindi, il cieco fine di evitare che il carcere diventasse una scuola di criminalità. In ogni modo, dopo essere stato considerato un modello da imitare, il carcere di Philadelphia fu costretto a chiudere a causa del sovraffollamento e per il ripensamento dei criminologi statunitensi in ordine alla funzione dell’isolamento.
Tale sistema viene, in seguito, adottato dal Granducato di Toscana nel 1853. Su di esso si sarebbe espresso il già citato Cesare Lombroso, pur sempre ai limiti tra il genio e la follia: quest’ultima nel momento in cui nega che l’isolamento nelle celle non avrebbe provocato né l’aumento dei suicidi né i casi di follia tra i detenuti; il genio, invece, nel ritenere praticamente illusoria la possibilità di rieducare il reo attraverso l’isolamento, cosicché, di concerto con altri esponenti della Scuola Positiva di diritto penale, cerca di proporre pene alternative alla detenzione di cui, tra l’altro, si discute tuttora. Tuttavia, la problematica della vecchiaia del sistema sanzionatorio non è una prerogativa esclusivamente italiana. Ad esempio, ancora oggi in molti Paesi medio-orientali vige la legge del taglione, secondo cui al crimine commesso deve seguire la (s)proporzionata conseguenza. E interessante è il fatto che una Nazione come gli Stati Uniti, che tanto prende le distanze dai suddetti Paesi, sostanzialmente altro non faccia se non porre in essere, in taluni suoi Stati, la medesima legge mediante l’applicazione della pena di morte. A tal proposito, è curioso analizzare l’etimologia della parola criminalità, in quanto essa deriva dall’antico verbo greco krino, poi divenuto il verbo latino cerno-is, vale a dire dare un giudizio, una decisione giudiziaria. Quindi, sostanzialmente, si potrebbe azzardatamente concludere che coloro che dovrebbero garantire la sicurezza e l’ordine sociale, alla fine siano i primi a commettere un crimine.