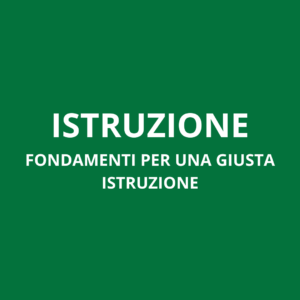D(ISTRUZIONE)
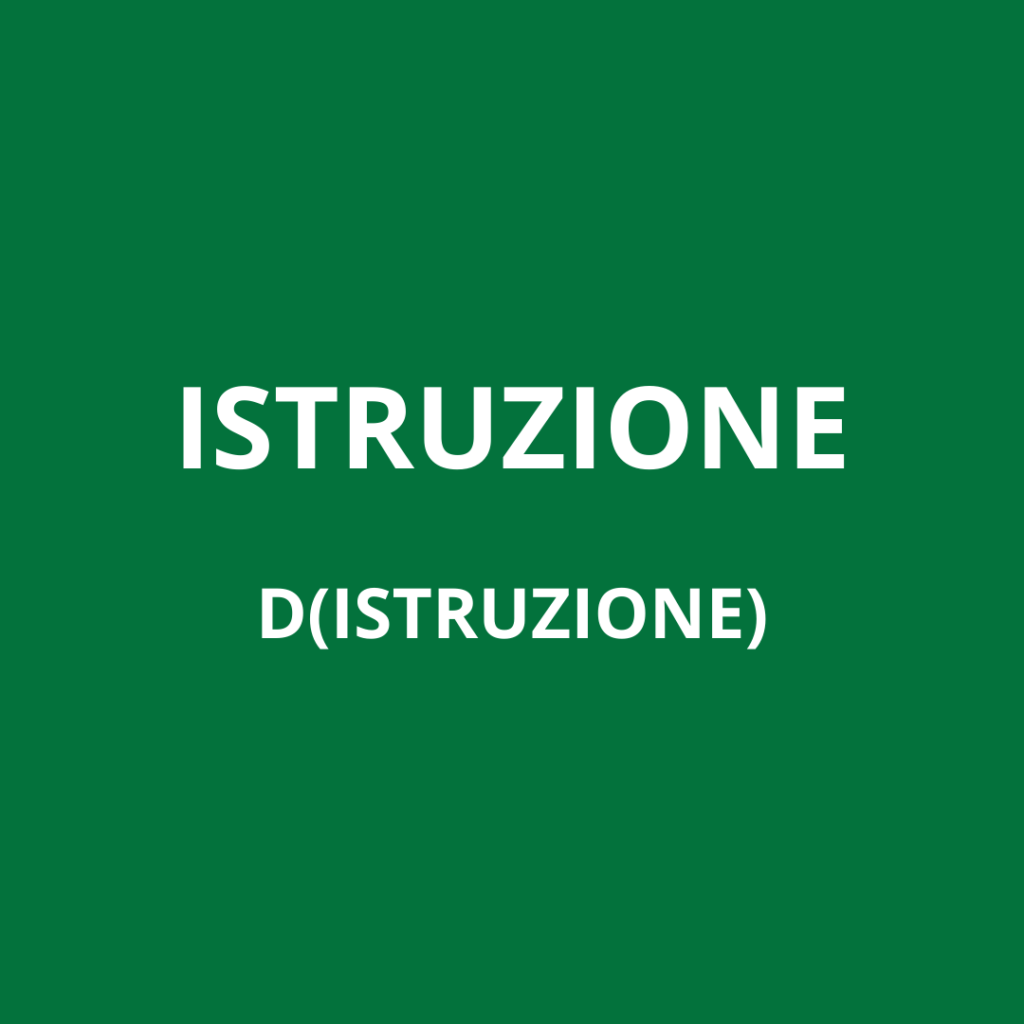
Il mezzo principale tramite cui si veicola l’organizzazione dell’istruzione è il sistema scolastico, ad oggi altamente adiuvato dai molteplici device multimediali. Il fine primario di tale realtà accademica risiede nell’ambizione di garantire la miglior istruzione possibile.
Quest’ultimo obiettivo assume una posizione centrale già dai primi anni del Novecento, per poi divenire uno dei punti fondamentali dell’immediato primo dopoguerra e del conseguente governo Mussolini attraverso la riforma Gentile. Tuttavia, ben presto è emerso il reale intento della suddetta riforma: piuttosto che lavorare al fine di permettere l’accesso all’istruzione a pressoché tutte le classi sociali, il nuovo sistema scolastico si sarebbe rivolto esclusivamente agli appartenenti alla borghesia, coinvolgendo in primo luogo la classe docente, ora chiamata a formare la futura classe dirigente.
Merita proprio ricorrere ad una breve digressione in ordine alla modalità con cui maestri e professori venivano selezionati in accordo con la riforma, in quanto essi venivano reclutati sulla base di valutazioni altamente teoriche, all’interno delle quali venivano principalmente testate le qualità oratorie dei futuri insegnanti.
La domanda retorica sorge spontanea: perché affidare questo lavoro a persone esperte e in grado di trasmettere il piacere della scoperta, quando la stessa mansione può essere svolta da individui innegabilmente capaci, ma soltanto di programmare ciecamente le menti di giovani studenti? Infatti, se il fine massimo delle scuole secondarie era di pervenire alla glorificazione della Nazione, soprattutto i ragazzi delle scuole elementari sono stati presi di mira dal riformista Gentile, i quali si sarebbero trovati coinvolti in quell’Opera Nazionale Balilla il cui fine non era tanto quello di formare la tanto ambita nuova classe dirigente, bensì una nuova generazione di persone altamente acculturate del mito del super-uomo, della violenza e della Nazione.
Ad oggi, sebbene non più sulla base degli insegnamenti di epoca fascista, sembra ormai essersi consolidato il messaggio implicito per cui soltanto un’elevata preparazione accademica permetta di raggiungere un considerevole livello di benessere economico e sociale. In questo modo, combattendo una presunta guerra contro l’impreparazione e l’oziosità dei giovani, i vecchi difensori della perfezione intellettuale paiono dimentichi del fatto che, oscurate dalla categoria studenti, ci siano persone con propri talenti, ambizioni e interessi. Di conseguenza, il principale obiettivo che un tale assetto scolastico è in grado di raggiungere è la formazione di personalità che, poi, muovono nella società sulla base di accezioni nervose ed ansiogene, aggressive e competitive, insicure e depressive.
Lo scopo cardine del suddetto sistema scolastico si esplica nella costante preoccupazione degli studenti di ottenere ottimi risultati, di modo che possano apparire costanti e grandiosi agli occhi di tutti coloro che, all’interno dell’attuale società, introiettano nelle loro menti l’erroneo ed irraggiungibile conseguimento della perfezione. D’altra parte, come sarebbe possibile alimentare quella cultura narcisista rappresentante il principale attributo della nostra epoca storica? Se Christopher Lasch, negli anni ’70 del secolo scorso, riteneva che tale cultura si sarebbe sempre più sviluppata a causa dell’allora devozione servile ai mezzi di comunicazione digitali che, ignorando la sostanza e la profondità di cose e persone, prosperavano su immagini superficiali, ad oggi la generazione del Terzo Millennio starebbe vivendo un’ulteriore fase di cultura narcisista, ossia una versione invasa da ricorrenti discorsi su autostima e, per l’appunto, narcisismo.
La scuola, insieme ai sottili indottrinamenti che impone, non aiuta i giovani della suddetta generazione a fuggire da un imperante senso del diritto finché non comprenderà che l’apprendimento non ha come fine il conseguimento di gratificazioni immediate e di sostegno all’autostima in qualsiasi momento della giornata da parte di un pubblico virtuale. Al contrario, la scuola dovrebbe dare forma alla matrice della maieutica socratica dell’io so di non sapere, affinché essa divenga il luogo dove scoprire il piacere di amare la conoscenza, piuttosto che una mera costruzione architettonica in cui viene introiettata la sapienza di piacere. Inoltre, un siffatto meccanismo rallenta l’apprendimento sia di coloro meno portati per gli studi (costantemente apostrofati e giudicati da familiari, docenti e amici) sia di quelle persone che, invece, non incontrano particolari, o nessuna, difficoltà (nonostante l’elevato rendimento scolastico, la pressione del risultato cui sono sottoposte ostacola l’agevole conseguimento dei propri obiettivi).
È evidente che l’attuale conformazione scolastica, fatta di gradi, aspettative, ansie ed esami sempre più complessi, non si adegui all’originale disegno pensato per l’istruzione, intesa come momento in cui le menti possono conversare e discutere criticamente tra di loro al fine di sviluppare pensieri e capacità proprie. In altre parole, sin da piccoli la scuola dovrebbe adiuvare la persona nella scoperta, nel nutrimento e nella finale esplosione dei propri talenti e passioni (capacità, hobby, interessi). Inoltre, dovrebbe essere il mezzo principale tramite cui i ragazzi possano effettivamente raggiungere i propri obiettivi, essere se stessi, realizzarsi, ma soprattutto sentirsi apprezzati per ciò che sanno di sapere e che possono offrire al mondo. In ogni modo, nucleo fondamentale di questa impostazione resta il fatto che a crescere non sono degli automi inermi, bensì delle persone i cui bisogni devono essere rispettati e sfamati anche dal sistema dell’istruzione. Soprattutto, in aggiunta ai fondamentali sistemi motivazionali costituiti dai legami di attaccamento, dal contenimento pulsionale, dallo sviluppo di istanze Super-Egoiche e caratteriali, così come dalla socializzazione anche mediante il gioco (la ricreazione), la scuola deve divenire il tempio della pulsione epistemofilica, ossia di quella connaturata spinta alla conoscenza, che solo può essere sorretta da una scuola che crei opportunità di apprendimento veicolanti motivazione e benessere.
Riferimenti e suggerimenti bibliografici
Balilla. Retrieved 26 gennaio, 2024, from Enciclopedia Online Treccani. https://www.treccani.it/vocabolario/balilla/.
La riforma Gentile. Retrieved 26 gennaio, 2024, from Enciclopedia Online Treccani. https://www.treccani.it/enciclopedia/la-riforma-gentile_%28Croce-e-Gentile%29/.
Mancini, G., Naldi, A., Agosta, R. (2023). Strumenti e progettualità dello psicologo a scuola. Psicologia in pratica. Educazione e formazione. Il Mulino.