LA FABBRICA DELLE RELIGIONI
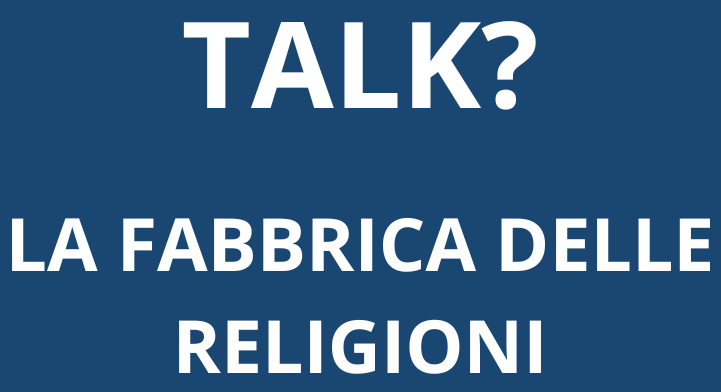
La contraddizione in questa guerra contro la morte, ossia usare la morte stessa al pari di uno strumento di persuasione per plasmare le opinioni dei singoli al pensiero di gruppo e alimentare la grandiosità dell’Io di quella Società per Azioni chiamata Chiesa
Tutti gli esseri viventi, quantomeno una più che considerevole porzione della popolazione mondiale teme la morte. Tale paura si conforma al funzionamento mentale degli uomini, ossia allontanare dal Sé l’ignoto, non parlarne e relegarlo nella cartella sociale dei tabù in quanto trasformazione inconcepibile dall’essere al non-essere.
Tuttavia, se si considera il rapporto dell’essere umano con la morte nel corso dei secoli, non sarebbe corretto immaginare quest’ultimo in termini di correlazione positiva, secondo cui ad un aumento della civilizzazione corrisponderebbe una maggiore paura della morte. Ad esempio, gli antichi Ebrei consideravano i cadaveri al pari di scorie radioattive che non devono entrare in contatto con il corpo vivente; similmente i Nativi d’America, credendo nella sopravvivenza degli spiriti cattivi, cacciavano questi ultimi scoccando in aria delle frecce e allo stesso tempo seppellivano i congiunti con i loro averi. Ancora, molte altre civiltà antiche hanno promosso specifiche usanze al fine di vigilare sui morti: per rimandare ad una pratica vicina alla nostra cultura, si pensi al costume di sotterrare i defunti, piuttosto che ridurli in cenere tramite cremazione.
Già differente è il modo di guardare alla morte da parte degli antichi egizi, i quali vivevano consapevoli che l’esistenza nell’aldilà sarebbe stata coerente ai comportamenti tenuti nel mondo dei vivi. Analogamente, seppur senza le pratiche dell’imbalsamazione e della mummificazione, i Greci e i Romani ornavano le stanze funebri con cibo, bevande e altri doni affinché il defunto fosse pronto ad iniziare una nuova vita.
La concezione appena riportata permane tale fino alla seconda metà del XII secolo, periodo in cui la morte perde il suo significato di fatto riguardante la collettività per divenire un avvenimento meramente individuale, la mia morte. E così, con il trascorrere dei secoli, si acuisce sempre più la paura degli uomini in ordine alla morte, in quanto avvenimento che l’essere umano non è stato, e non sarà mai, in grado di dominare.
Per riuscire ad adiuvare una psiche già messa a dura prova dal pensiero della morte, ecco comparire ad un certo momento la religione nella cassetta degli attrezzi delle persone. Originariamente di natura essenzialmente antropomorfica e politeistica, la religione costituisce da tempo immemore quel legame inossidabile tra l’individuo, mortale e imperfetto, e le divinità, onnipotenti e perfette. In ogni modo, si tratta di un rapporto quasi paritetico, all’interno del quale il divino accompagna la persona in tutte le sue esperienze quotidiane, morte inclusa. Ecco, dunque, che il contadino dell’Antica Roma attribuisce un buon raccolto alla benevolenza della dea Annona, mentre l’Egizio venera Anubi affinché possa proteggere nel mondo dei morti il parente defunto.
Inoltre, i culti religiosi delle origini lasciano spazio ai loro aspetti più conturbanti e ambigui, permettendo al fedele di oscillare costantemente tra attrazione e repulsione in ordine alla religione. Di converso, con l’avvento delle prime grandi religioni monoteistiche è completamente svanita la liminalità tra il fascinans et tremendum insita in qualsiasi religione sino a quel momento esista, per lasciare spazio all’imposizione della netta separazione tra buono e cattivo, tra bene e male, tra vita e morte.
Ad esempio, senza imporre la suddetta separazione tra bene e male, i Britanni veneravano l’entità ctonia chiamata Hel, dea degli inferi il cui corpo è diviso in due: una parte assume le sembianze di un teschio e di uno scheletro, l’altra di una donna bellissima, così da veicolare allo stesso tempo messaggi positivi e negativi, di morte e di vita, di bello e di brutto.
Altro esempio è costituito dalle itako giapponesi, ossia donne cieche dalla nascita che permetterebbero ai vivi di entrare in contatto con il mondo dei morti tramite il kegare, ossia la massima espressione dell’unione tra vita e morte.
Con l’avvento della prime grandi religioni monoteistiche il discorso sulla religione cambia notevolmente, forse proprio a causa della tematica di cui si è discusso in precedenza: la paura della morte. Ecco, dunque, che quest’ultima viene attaccata da insegnamenti di pace eterna e di speranza di una nuova vita nella morte, così da negare ulteriormente la propria mortalità. Al tempo stesso, tuttavia, i fedeli fuggono costantemente dalla morte ricorrendo a meccanici riti cerimoniali a causa dell’incapacità nel gestire una nuda morte. In ogni modo, più che onorare e mostrare rispetto al defunto, questi cerimoniali sembrano svolgere un più importante ruolo sociale, ossia di comunicare stabilità e, in un certo senso, confermare ai vivi l’irreversibilità della morte. In parole povere, “oggetto manifesto è il morto ma […] è per coloro che restano […] che in realtà viene celebrato il rituale” (Bowlby, 1980, p. 126).
Con il progredire dell’artificialità religiosa, la paura della morte dei singoli individui ha subito uno spostamento di oggetto verso quella che è divenuta una vera e propria fobia della morte del proprio credo a causa di un funzionamento paranoideo della religione, che si sente costantemente attaccata da coloro in essa non rientranti. Forse l’esempio più emblematico di guerre religiose si riferisce alle Crociate, combattute tra l’XI e il XII secolo su volere della Chiesa di Roma, aventi lo scopo di sottrarre la Terra Santa dal dominio islamico. Oppure, si pensi alla guerra tra Inghilterra (cristiano-protestante) e Spagna (cristiano-cattolica) di metà XVII secolo, così come alle molte guerre intra-religiose che hanno visto scontrarsi valdesi, protestanti, luterani e ortodossi.
Tutti appartenenti alla Religione Cristiana, che, tralasciando gli episodi di estremismo religioso, può essere considerata l’artefice di molte guerre e violenze. Due sono gli esempi in proposito: il primo si riferisce agli abusi, alle violenze fisiche e sessuali (comprendenti elettroshock e sterilizzazioni) e alle uccisioni perpetrati a danno di circa 150.000 Nativi Americani; il secondo avvenimento, reso noto solo il 20 maggio 2009, concerne vessazioni, umiliazioni, violenze e abusi fisici e sessuali per mano delle Suore della Misericordia e dei Fratelli Cristiani d’Irlanda su bambini e giovani madri costretti a lavorare presso le cosiddette lavanderie Magdalene.
Cercando un significato in quanto sin qui riportato, due possono essere le interpretazioni. Da un lato, ritorna il meccanismo difensivo dell’attacco-fuga di cui sopra, con l’aggiunta del fatto che ora a dover essere protetta non è soltanto la vita del singolo fedele, bensì anche quella dell’intero sistema religioso. Se i nemici che l’esercito cattolico è stato in grado di uccidere durante la Crociate sono venti volte più numerosi delle perdite subite (attacco), allora la popolazione cattolica si sentirà immune alla morte (fuga). Si tratterebbe della proiezione nel mondo di quell’universale ed infantile desiderio di onnipotenza e di immortalità, che consentirebbe ad interi gruppi di persone di rinnegare la morte con difese che non potranno che essere solo distruttive.
Dall’altro lato, potrebbe risultare fondamentale un uso machiavellico-narcisistico della paura della morte dei fedeli da parte delle aristocratiche istituzioni religiose al solo fine di mantenere, e talora acquisire, consensi e fedeltà al credo.
Si è raggiunto l’apice dell’artificialità ormai insita in qualsiasi fede religiosa, nel senso che da strumento ausiliario agli esseri umani nella loro quotidiana lotta contro la sofferenza e le avversità, la religione ha perso la naturalezza delle sue funzioni e delle sue cerimonie per divenire una corporazione di istituzioni illusorie e illudenti che giocano sulle debolezze e sulla paura dei fedeli nei confronti del diverso, del non convenzionale, financo della morte.
Con riferimento alla realtà religiosa a noi più vicina, ossia la Chiesa Cristiano-Cattolica, è possibile parlare di una vera e propria massa artificiale, che per impedire la propria dissoluzione fa ricorso ad una coercizione esterna, nel senso che se l’ingresso in una tale massa altamente organizzata non è sottoposto ad alcun vaglio, invece provare ad uscirne è un’operazione più ardua, in quanto severamente punita o comunque vincolata a stringenti condizioni. Ad ulteriore protezione contro la disgregazione della suddetta massa vige l’illusione dell’esistenza di un Capo Supremo (Dio) che, nella classica metafora della famiglia, ama tutti i suoi fratelli come se stesso. Infatti, recita così il Vangelo di Matteo: “in quanto l’avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, voi l’avete fatto a me” (25; 40).
In altri termini, le istituzioni religiose si articolano in strutture libidiche in cui l’amore del singolo nei confronti del Capo Supremo, nel quale è collocata una fiducia irrazionale e illimitata, funge da collante tra i singoli membri della popolazione religiosa, con il conseguente affiorare di una mentalità di gruppo il cui limite consiste nel non rappresentare gli obiettivi consapevoli dei suoi singoli componenti, bensì i comuni ed ignoti scopi del gruppo. Al singolo membro è richiesta una partecipazione non consensuale al pensiero di gruppo alla quale egli non si opporrà per non vedere sgretolarsi l’attesa messianica di salvezza e pace eterne promesse da Dio.
Di converso, il cieco amore nei confronti del Cristo ingenera spietate ed ostili pulsioni nei confronti delle altre persone non conformi e non conformantesi al credo. Quest’ultima riflessione è chiaramente utilizzabile con qualsiasi religione, ciascuna delle quali è sempre più retta da potenti istituzioni pronte ad introiettare i propri dogmi nelle teste dei fedeli e, parallelamente, ad allontanare spietatamente coloro che non li condividono. Parafrasando Freud, l’amore di ciascuna massa religiosa si dimostra nei confronti di coloro che ne abbracciano il credo, mentre per coloro che non ne fanno parte rimangono intolleranza e crudeltà.
Sempre assumendo come riferimento principale la Chiesa di Roma, ad oggi si potrebbe parlare esclusivamente di Chiesa istituzionale, vale a dire di quella che si configura come una vera e propria organizzazione gerarchica di cui il clero costituisce l’élite dominante sulla comunità laica dei fedeli. A tal proposito, il Canone 207 del Codice di diritto canonico asserisce che “Tra i fedeli vi sono nella Chiesa, per istituzione divina, i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici, e gli altri fedeli, che sono chiamati anche laici”.
Di per sé, già solo quanto appena riportato è sufficiente per sottolineare l’innaturalità delle istituzioni religiose, le quali non si ispirano alle iperboli contenute nella Bibbia e nel Vangelo, bensì necessitano di rigide regole scritte inerenti il Diritto Canonico (tutto ciò che concerne la legislazione interna alla Chiesa cattolica) e il Diritto Ecclesiastico (espressione del diritto statale nella gestione giuridica delle confessioni religiose).
Si tratta di una struttura politica umana creata da uomini per altri uomini. Da sottolineare l’espressione da uomini per altri uomini, in quanto rimanda ad una casta misogina che vede ancora la donna come espressione della tentazione e del peccato. D’altra parte, secondo la Bibbia, Gesù sarebbe nato da Maria per opera dello Spirito Santo, non in seguito ad un rapporto sessuale tra la prima e Giuseppe.
L’artificialità della Chiesa di Roma e delle sue istituzioni è retta dal clericalismo, ossia da quella concezione secondo cui il clero costituisce una popolazione religiosa indipendente e sopraelevata rispetto al resto della comunità di fedeli, e al tempo stesso rappresentante in Terra di Dio e da Lui solo giudicabile. Il clericalismo può essere inteso come la manifestazione di un Sé-sistemico ipertrofico e narcisistico derivante dall’unione di un Sé e di un oggetto ideali con il Sé reale: la Chiesa istituzionale (Sé ideale), fondendosi con la Chiesa cattolica pastorale (Sé reale) e con la comunità laica ad essa fedele (oggetto ideale), darebbe origine ad una personalità narcisistica che nega valore alla stessa comunità religiosa non rientrante nell’élite clericale. In sostanza, si tratterebbe di un’istituzione connotata da un irreale ed invulnerabile senso di autonomia alimentato da pensieri e fantasie grandiose provenienti da un altro appartenente alla cricca dei Capi Supremi (il Pontefice).
Ora, anche in una prospettiva di sanità mentale, emerge l’inutilità dei dogmi e delle regole imposti dalle istituzioni religiose, il cui unico scopo è di introiettare nelle singole persone concetti molto spesso non condivisi e irrazionali, senza concedere ai singoli di credere e pensare a ciò che vogliono senza conformarsi illusoriamente al pensiero di gruppo. Potenzialmente, se fosse vera e accertata l’esistenza di Dio, o di un’altra entità sovrannaturale rivelatasi all’uomo in epoche passate, tutti gli uomini professerebbero la medesima religione. Dunque, l’esistenza di diversi dogmi costituirebbe la prova dell’esistenza artificiale di ogni religione, nonché della bravura dell’uomo nel costruirla.
Riferimenti e suggerimenti bibliografici e filmografici
Bowlby, J. (2004). Attaccamento e perdita. La perdita della madre. Bollati Boringhieri Editore.
Frawley-O’Dea, M.G., Goldner, V. (2009). Atti impuri. La piaga dell’abuso sessuale nella Chiesa cattolica (Stefania De Petris, Trans.). Raffaello Cortina Editore.
Freud, S. (2012). Psicologia delle masse e analisi dell’Io (E.A. Panaitescu, Trans.). Bollati Boringhieri Editore. (Original work published 1921).
Gabbard, G.O. (2015). Psichiatria psicodinamica. Quinta edizione basata sul DSM-5® (Maria Luisa Madeddu, Trans.). Psichiatria, Psicoterapia, Neuroscienze. Collana diretta da Vittorio Lingiardi. Raffaello Cortina Editore.
Kübler-Ross, E. (2008). La morte e il morire (Clara di Zoppola, Trans.). Prefazione di Annamaria Marzi. Psicoguide. Cittadella Editrice. (Original work published 1976)
La morte nei secoli. Retrieved 19 aprile, 2008, from Storia digitale. Contenuti online per la storia. https://www.storiadigitale.it/la-morte-nei-secoli/.
Quaglia, R., Longobardi, C. (2012). Modelli evolutivi in psicologia dinamica. Volume primo. Dal modello pulsionale alle relazioni oggettuali. Raffaello Cortina Editore.The Magdalene Sisters (2002). Regia di Peter Mullan.


